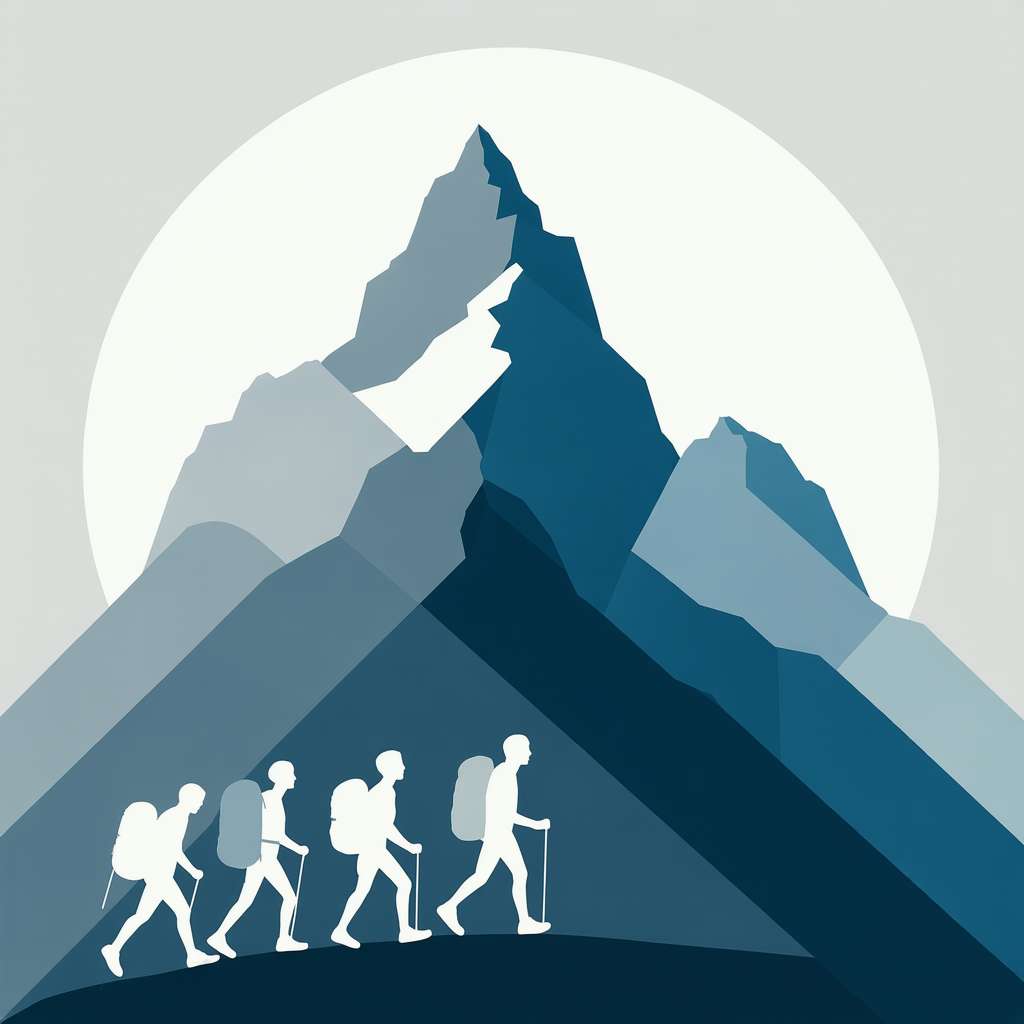E-Mail: [email protected]
- Le Alpi Apuane sono al centro di un dibattito sull'estrazione intensiva del marmo e le sue conseguenze ambientali, con il 33% della superficie delle cave rappresentato dai "beni estimati".
- Il Piano regionale cave (Prc) della Toscana, pur imponendo un rapporto massimo di 25 a 75 tra blocchi estratti e detriti, spesso vede percentuali di detriti raggiungere il 90-95% a causa di un sistema di premialità.
- Nel 2003 i periti del tribunale attribuirono la responsabilità delle alluvioni anche alle cave, mentre il canone complessivo pagato all’amministrazione dalle circa 70 cave in concessione ammonta a circa 23 milioni di euro annui.
Il cuore bianco delle Apuane: un equilibrio fragile
Le Alpi Apuane, custodi di un ecosistema prezioso e di una bellezza scultorea, si ergono come un monumento naturale plasmato dal tempo. Nel loro cuore, il marmo, una risorsa che alimenta l’economia locale da secoli, è al centro di un acceso dibattito. L’estrazione intensiva di questo materiale pregiato solleva interrogativi sulla sostenibilità di tale attività e sulle conseguenze che essa comporta per l’ambiente. Le montagne, modellate dalle cave, non sono solo un paesaggio, ma un patrimonio naturale da proteggere. L’equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale è la sfida cruciale per il futuro di questo territorio. Le Apuane, con le loro vette imponenti, sono un palcoscenico dove si confrontano interessi divergenti e visioni contrastanti. Da un lato, l’industria del marmo, motore di un indotto significativo; dall’altro, le comunità locali e le associazioni ambientaliste, custodi di un patrimonio da salvaguardare. In questo contesto, il recente convegno sulla distruzione della montagna nel Parco delle Apuane ha riacceso i riflettori su una questione complessa e stratificata. Si tratta di un’indagine approfondita sull’impatto dell’industria del marmo sull’ambiente, un’analisi degli interessi economici in gioco, delle concessioni minerarie e delle possibili alternative per uno sviluppo sostenibile. Le Alpi Apuane, con il loro marmo candido, rappresentano una sfida per l’alpinismo moderno e la gestione del territorio montano. Il turismo consapevole e la valorizzazione del patrimonio culturale sono leve fondamentali per un futuro sostenibile. L’alpinismo moderno, sensibile alle tematiche ambientali, può contribuire a promuovere una fruizione rispettosa di questo territorio.

Economia e ambiente: un binomio complesso
L’attività estrattiva del marmo genera un indotto economico rilevante, creando posti di lavoro e contribuendo in modo significativo al prodotto interno lordo (Pil) locale. Tuttavia, dietro questa facciata di prosperità economica, si celano interessi complessi e un sistema di concessioni minerarie che solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’equità. Le associazioni ambientaliste denunciano da tempo la mancanza di controlli adeguati e la scarsa trasparenza nella gestione delle risorse, evidenziando come il profitto economico possa prevalere sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia del paesaggio. Il Piano regionale cave (Prc) della Toscana, che stabilisce un rapporto massimo tra la quantità di blocchi estratti e i detriti di lavorazione, è spesso oggetto di critiche. Sebbene il Prc imponga un rapporto massimo di 25 a 75, in alcune cave la percentuale di detriti può raggiungere il 90-95% grazie a un sistema di premialità. Questa disparità solleva dubbi sull’efficacia dei controlli e sulla reale volontà di limitare l’impatto ambientale dell’attività estrattiva. La storia delle concessioni minerarie affonda le radici nel passato, risalendo a un editto del 1751 che consentiva ai “particulari ventennali” di estrarre marmo liberamente. Questo privilegio si è tramandato di generazione in generazione, fino agli attuali proprietari dei cosiddetti “beni estimati”. La mancata ricognizione di questi beni, sollecitata più volte, alimenta le polemiche e le accuse di favoritismi. I “beni estimati” rappresentano circa il 33% della superficie delle cave. Nel 2003 i periti del tribunale attribuirono la responsabilità delle alluvioni anche alle cave. Il canone complessivo pagato all’amministrazione dalle circa 70 cave in concessione ammonta a circa 23 milioni di euro annui.
Un ecosistema fragile sotto assedio
L’impatto ambientale dell’estrazione del marmo è un tema di grande attualità e preoccupazione. Le cave, con i loro profondi tagli nella montagna, alterano irreversibilmente il paesaggio, compromettendo la stabilità dei versanti e aumentando il rischio di frane e smottamenti. L’erosione del suolo, la perdita di biodiversità e l’inquinamento delle acque sono altre conseguenze dirette dell’attività estrattiva. Le polveri sottili, generate dall’estrazione e dalla lavorazione del marmo, contribuiscono all’inquinamento atmosferico, con ripercussioni negative sulla salute umana. La “marmettola”, lo scarto dell’estrazione, rappresenta un’ulteriore minaccia per l’ambiente. Questo materiale, composto da polvere di marmo e acqua, inquina le falde acquifere e i corsi d’acqua, cementificando il letto dei fiumi e torrenti e aumentando il rischio di esondazioni. Studi recenti hanno evidenziato come la marmettola, spesso contaminata da lubrificanti, oli e metalli pesanti, possa compromettere la vita delle specie vegetali e animali che popolano i fiumi. La rimozione delle antiche discariche di cava, i ravaneti, per estrarre carbonato di calcio, impedisce alle Apuane di svolgere la loro funzione di serbatoio naturale di acqua piovana, aggravando il rischio di alluvioni. L’assessore Anna Marson propose un Piano Paesaggistico che fu stravolto da una pesante azione di lobby dei cavatori. Il parco delle Apuane, istituito su grosse pressioni da parte di speleologi, escursionisti, alpinisti, è un parco del tutto anomalo in cui si tutela a macchia di leopardo. Le escavazioni vanno a intaccare anche le falde acquifere, in un periodo come il nostro in cui l’acqua è un bene sempre più prezioso. Il business principale è il carbonato di calcio, settore in cui è molto attiva la multinazionale svizzera Omya. Raul Gardini vinse l’appalto con l’Enel per fornire i filtri per le centrali a carbone, filtri che si realizzano appunto con la polvere di marmo, cioè il carbonato di calcio. A essere ottimisti del marmo estratto solo lo 0,5% va all’attività scultorea.
Un futuro sostenibile per le Apuane: è possibile?
Di fronte a questa complessa situazione, è fondamentale individuare alternative concrete per uno sviluppo sostenibile del territorio. Un approccio equilibrato deve tenere conto delle esigenze economiche della comunità locale, senza compromettere la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio per le future generazioni. Tra le possibili soluzioni, si possono annoverare: la promozione di un’attività estrattiva più responsabile e controllata, la diversificazione dell’economia locale attraverso il turismo sostenibile e l’agricoltura di qualità, la valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico del Parco delle Apuane. Il Coordinamento apuano ha elaborato un piano di sviluppo alternativo (Pipsea) che prevede la suddivisione del territorio in tre macro aree: una da salvaguardare integralmente, una da riconvertire con attività agricole e artigianali, e una in cui l’attività di cava continuerebbe per la trasformazione in loco, privilegiando la filiera corta e la valorizzazione del prodotto locale. Il vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, monsignor Mario Vaccari, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione, sottolineando come il pericolo sia che non ci siano ritorni sulla cittadinanza di una ricchezza che è demaniale, creando una disuguaglianza inquietante. Eros Tetti, fondatore del movimento “Salviamo le Apuane”, ha denunciato come nessuna forza politica abbia mai preso in considerazione la possibilità di un intervento per ridurre l’impatto delle cave. Il Piano Paesaggistico è stato “completamente stravolto da una pesante azione di lobby dei cavatori” e il Parco regionale è “un parco del tutto anomalo”, che lascia fuori le aree di interesse economico. “Si estrae la pietra solo per destinarla a lavorazioni industriali”, ha affermato Tetti, denunciando l’assurdità di consentire per legge di estrarre tre tonnellate di detrito per ogni tonnellata di marmo. Nel 2015 si fece promotore di un “Manifesto per le Alpi Apuane”, sottoscritto dalle maggiori associazioni ambientaliste italiane e da personalità come Vandana Shiva, Salvatore Settis, Alberto Asor Rosa, Tomaso Montanari. Il PIPSEA – Piano Programma per lo Sviluppo Alternativo per le Apuane – è una proposta partita dal basso redatta insieme a esperti di vari settori che propone un futuro sostenibile per questa catena montuosa. Il piano divide il territorio delle Apuane in tre zone: una prima zona da salvaguardare integralmente, non ancora toccata dalle cave; una seconda zona, già parzialmente compromessa, in cui si andrebbe verso una conversione delle attività di cava, con lo sviluppo di attività agricole e artigianali; una terza zona in cui l’attività di escavazione continuerebbe anche se votata principalmente alla trasformazione in loco. Eppure ci sono circa 800 cave in totale, fra attive, dismesse, saggi di cava, di cui quasi 200 attive.
Oltre la candida superficie: il futuro delle Apuane
La questione delle Alpi Apuane ci pone di fronte a una sfida più ampia: come conciliare lo sfruttamento delle risorse naturali con la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio? La risposta non è semplice e richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolga le istituzioni, le imprese, le comunità locali e le associazioni ambientaliste. È necessario superare le logiche contrapposte e costruire un dialogo costruttivo, basato sulla trasparenza, sulla responsabilità e sulla condivisione degli obiettivi. L’alpinismo moderno, con la sua sensibilità per le tematiche ambientali e la sua attenzione alla sostenibilità, può svolgere un ruolo importante in questo processo. Promuovere un turismo consapevole, che rispetti l’ambiente e valorizzi il patrimonio culturale e naturalistico delle Apuane, può rappresentare un’alternativa economica valida e sostenibile. L’alpinismo, in questo contesto, non è solo una pratica sportiva, ma anche un’opportunità per conoscere, apprezzare e proteggere un territorio unico al mondo. Bisogna preservare l’ambiente e imporre un piano per la sicurezza per preservare la salute dei lavoratori: qui abbiamo un incidente in cava ogni due giorni. Formalmente, la regione Toscana fa della tutela del paesaggio il suo punto di forza. Il parco fu costituito su grosse pressioni da parte di speleologi, escursionisti, alpinisti. Ma è un parco del tutto anomalo, forse l’unico parco in cui si tutela a macchia di leopardo.
Amici appassionati di montagna, riflettiamo un attimo su questo tema delicato. Forse non tutti sanno che le Apuane sono famose non solo per il marmo, ma anche per le vie di arrampicata, alcune storiche e di grande bellezza. Un eccessivo sfruttamento del territorio potrebbe compromettere anche questo aspetto. Dal punto di vista alpinistico avanzato, la questione delle Apuane solleva un tema cruciale: la responsabilità dell’alpinista nei confronti dell’ambiente montano. Non si tratta solo di evitare di lasciare rifiuti o di rispettare la flora e la fauna, ma anche di essere consapevoli dell’impatto che le nostre azioni possono avere sul territorio e di contribuire attivamente alla sua tutela.
La montagna è un bene prezioso, un patrimonio da proteggere per noi e per le generazioni future. Impariamo a viverla in modo consapevole e responsabile, perché solo così potremo continuare a godere della sua bellezza e della sua magia.