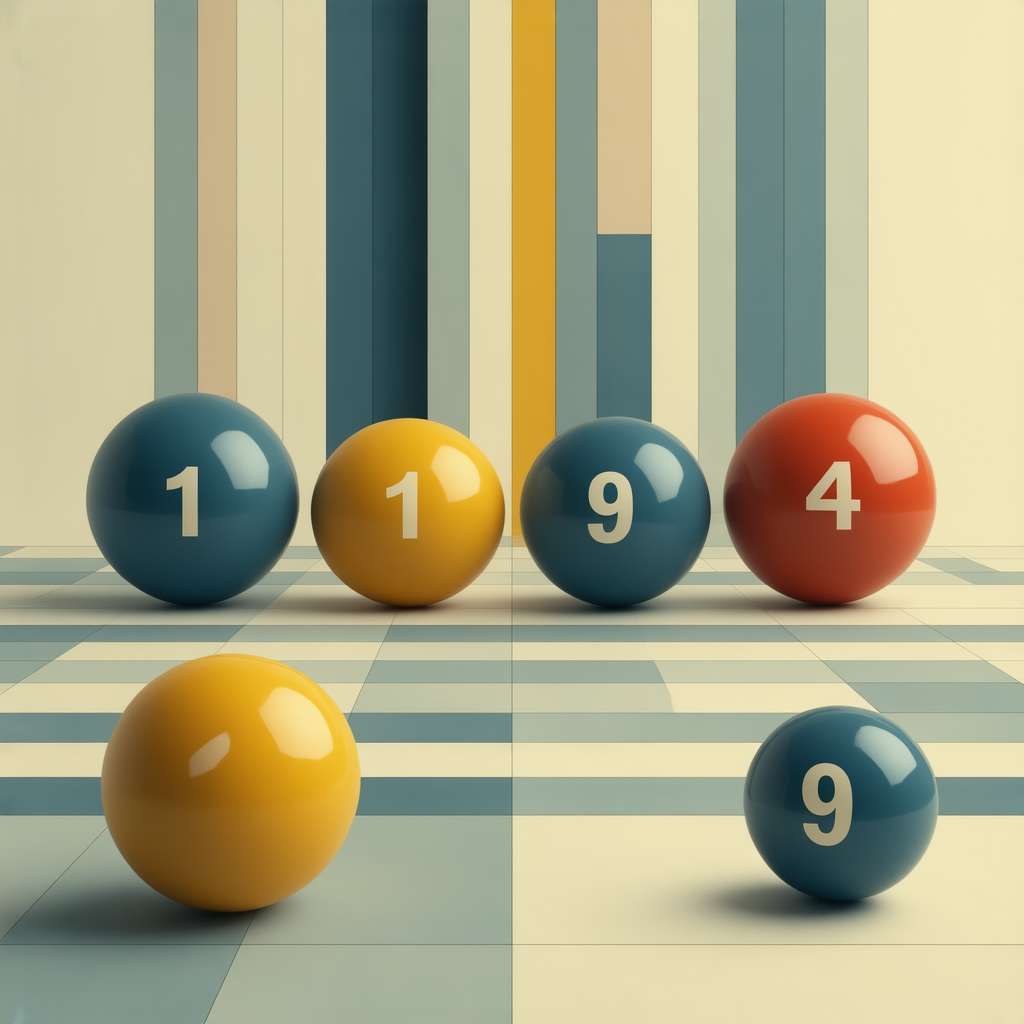E-Mail: [email protected]
- Il dissesto idrogeologico, acuito da eventi come le colate detritiche in Valsesia e Mompantero, è conseguenza di decisioni politiche ed economiche errate.
- L'abusivismo edilizio, la deforestazione e la costruzione di infrastrutture non adeguate sono tra i principali fattori antropici che contribuiscono al dissesto, mettendo a rischio la stabilità delle montagne.
- Paride Antolini, presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna, sottolinea che spesso il cambiamento climatico è usato come «una scusa per non agire sulle cause di questi fenomeni», evidenziando l'importanza del consumo di suolo zero.
- L'Italia è uno dei Paesi europei più vulnerabili al dissesto idrogeologico, con un'elevata percentuale di territorio classificato a rischio frane e alluvioni.
Le montagne, custodi silenziose del nostro pianeta, si innalzano come simboli di forza e tenacia. Eppure, questa visione ideale cozza con la dura realtà dei problemi idrogeologici, una questione che tormenta sempre più le comunità alpine. Disastri come le recenti colate detritiche in Valsesia e Mompantero non sono semplici fatalità naturali, ma la conseguenza di una serie di decisioni politiche ed economiche che hanno messo a repentaglio la sicurezza del territorio. L’edilizia illegale, la speculazione spietata e i controlli carenti hanno contribuito a creare un cocktail letale che minaccia la stabilità delle montagne e l’esistenza di chi le vive.
Il dissesto idrogeologico: una minaccia incombente
Il dissesto idrogeologico costituisce una delle sfide più impellenti per il nostro paese, specialmente per le zone montuose. Si tratta di un fenomeno complesso, generato da un insieme di elementi naturali e indotti dall’uomo, che può manifestarsi attraverso frane, cedimenti, inondazioni e altri eventi catastrofici. Gli effetti sono disastrosi: perdita di vite umane, danni alle strutture, distruzione di abitazioni e attività produttive.
Gli eventi franosi in Valsesia, precisamente nella frazione di Frasso nel comune di Scopello, e a Mompantero, sono un segnale d’allarme che non possiamo ignorare. Le piogge intense, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, hanno provocato movimenti di terra che hanno coinvolto case e infrastrutture, forzando l’evacuazione di molte famiglie. Fortunatamente, in questi specifici eventi, non si sono registrati feriti o vittime, ma il rischio di future catastrofi rimane elevato.
Le cause del dissesto idrogeologico sono svariate e intricate. Prima di tutto, la vulnerabilità intrinseca del territorio montano, contraddistinto da pendii scoscesi, terreni precari e un’alta predisposizione all’erosione. A questa fragilità naturale si sommano i fattori antropici, vale a dire le azioni umane che contribuiscono ad accentuare il pericolo. Tra questi, l’abusivismo edilizio, la deforestazione, la trascuratezza del territorio e la costruzione di infrastrutture senza adeguate misure di salvaguardia.
L’abusivismo edilizio rappresenta una delle calamità più gravi per le nostre montagne. L’edificazione di case e altri edifici in zone a rischio, senza il rispetto delle leggi e senza idonei lavori di consolidamento, accresce notevolmente la possibilità di frane e smottamenti. Sovente, i permessi di costruzione vengono rilasciati con troppa superficialità, senza un’attenta valutazione dei pericoli e senza un controllo efficace sull’attività edilizia.

Il ruolo delle amministrazioni locali e le responsabilità individuali
La gestione del territorio montano è una responsabilità condivisa tra diversi attori: le amministrazioni locali, i proprietari degli immobili, i professionisti del settore e i cittadini. Tuttavia, le amministrazioni locali svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Spetta a loro, infatti, pianificare il territorio, rilasciare i permessi di costruzione, effettuare i controlli e vigilare sul rispetto delle normative.
Troppo spesso, però, le amministrazioni locali si sono dimostrate inadeguate a questo compito. Controlli insufficienti, mancanza di risorse, conflitti di interesse e una generale mancanza di sensibilità verso la tutela del territorio hanno contribuito a creare una situazione di rischio elevato. È necessario un cambio di mentalità, un impegno concreto da parte delle amministrazioni locali per una gestione del territorio più responsabile e sostenibile.
Ma le responsabilità non sono solo delle amministrazioni locali. Anche i proprietari degli immobili hanno un ruolo importante da svolgere. Devono essere consapevoli dei rischi a cui sono esposti e adottare tutte le misure necessarie per proteggere le proprie case e le proprie famiglie. Devono inoltre rispettare le normative edilizie e non intraprendere interventi che possano aggravare il rischio idrogeologico.
Inoltre, è fondamentale che i professionisti del settore, come geologi, ingegneri e architetti, svolgano il loro lavoro con competenza e rigore, mettendo al primo posto la sicurezza del territorio e la tutela dell’ambiente. Devono essere in grado di valutare accuratamente i rischi, progettare opere di consolidamento efficaci e vigilare sul rispetto delle normative.
Le concessioni idroelettriche rappresentano un altro tema delicato, spesso al centro di polemiche e contestazioni. Se da un lato possono rappresentare una fonte di energia rinnovabile, dall’altro possono avere un impatto significativo sull’ambiente montano, alterando gli ecosistemi, modificando il regime idrico dei fiumi e aumentando il rischio di frane e smottamenti.
La creazione di bacini artificiali, ad esempio, può comportare la sommersione di valli e boschi, la distruzione di habitat naturali e la perdita di biodiversità. Inoltre, le dighe possono interrompere il flusso dei sedimenti, causando l’erosione delle coste e la riduzione della fertilità dei terreni a valle.
Alcuni studi hanno evidenziato che le inondazioni dei bacini idrici delle centrali elettriche possono immettere negli ecosistemi marini grandi quantità di metilmercurio, una neurotossina che si accumula nella catena alimentare, mettendo a rischio la salute delle popolazioni che vivono di pesca. Questo solleva interrogativi importanti sulla sostenibilità di questa forma di energia e sulla necessità di valutare attentamente i costi e i benefici prima di rilasciare nuove concessioni.
Paride Antolini, presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, ha sottolineato l’importanza di non attribuire esclusivamente ai cambiamenti climatici la causa dei fenomeni estremi: “Spesso, il cambiamento climatico viene indicato come la ragione di tutti i fenomeni estremi come le alluvioni o le esondazioni dei fiumi. In realtà si tratta di una scusa per non agire sulle cause di questi fenomeni. Il consumo del suolo può essere un fattore determinante. Insomma, è necessario fare un passo indietro e guardare al concetto di consumo del suolo zero”.
Antolini ha inoltre evidenziato la necessità di investire in tecnologia per il monitoraggio del territorio, ma ha sottolineato che “la tecnologia da sola non basta” e che è fondamentale un’evoluzione delle competenze professionali per comprendere e gestire al meglio lo sviluppo tecnologico.
Cambiamenti climatici e la loro influenza
I cambiamenti climatici rappresentano una sfida globale che ha un impatto significativo anche sulle zone montane. L’aumento delle temperature, la diminuzione delle precipitazioni nevose e l’aumento degli eventi meteorologici estremi stanno mettendo a dura prova la stabilità del territorio e la vita delle comunità alpine.
L’aumento delle temperature provoca lo scioglimento dei ghiacciai e del permafrost, il terreno perennemente gelato che si trova in alta quota. Questo fenomeno destabilizza i pendii e aumenta il rischio di frane e smottamenti. La diminuzione delle precipitazioni nevose, invece, riduce la capacità del terreno di trattenere l’acqua, aumentando il rischio di siccità e incendi boschivi.
Gli eventi meteorologici estremi, come le intense piogge e le tempeste di vento, sono sempre più frequenti e violenti a causa dei cambiamenti climatici. Questi eventi possono innescare frane e alluvioni, causando danni ingenti alle infrastrutture e alle abitazioni.
È necessario adottare misure urgenti per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e per adattarsi alle nuove condizioni ambientali. Questo significa ridurre le emissioni di gas serra, promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili, proteggere le foreste e gestire il territorio in modo più sostenibile.
Inoltre, è fondamentale investire nella ricerca scientifica per comprendere meglio gli effetti dei cambiamenti climatici sulle zone montane e per sviluppare strategie di adattamento efficaci. È necessario monitorare costantemente il territorio, prevedere i rischi e adottare misure di prevenzione adeguate.
La prevenzione del dissesto idrogeologico è un investimento a lungo termine che può salvare vite umane e proteggere il nostro patrimonio ambientale. È necessario agire con urgenza e con determinazione, coinvolgendo tutti gli attori interessati e adottando un approccio integrato e sostenibile.
Il rischio idrogeologico, alimentato da incuria e avidità, genera conseguenze tangibili e misurabili in termini di vite umane perse, sfollati e miliardi di euro spesi per riparare i danni. Le statistiche, purtroppo, parlano chiaro: l’Italia è uno dei Paesi europei più vulnerabili al dissesto idrogeologico, con una percentuale elevata di territorio classificato a rischio frane e alluvioni.
Questi dati, però, non devono scoraggiarci, bensì spronarci ad agire. La consapevolezza del problema e la conoscenza delle cause sono il primo passo per trovare soluzioni efficaci. È necessario diffondere una cultura della prevenzione, educare i cittadini al rispetto del territorio e promuovere una gestione del territorio più responsabile e sostenibile.
Verso una montagna resiliente: proposte e soluzioni
Di fronte alla complessità del problema, è necessario adottare un approccio integrato e multidisciplinare, che coinvolga diversi settori e competenze. È necessario unire le forze tra amministrazioni locali, proprietari degli immobili, professionisti del settore, associazioni ambientaliste e cittadini, per costruire una montagna più resiliente e sicura.
Innanzitutto, è fondamentale rafforzare i controlli sull’attività edilizia, per evitare la costruzione di case e altri edifici in aree a rischio. È necessario rivedere i criteri per il rilascio dei permessi di costruzione, adottando un approccio più prudente e rigoroso. È necessario effettuare controlli periodici sull’attività edilizia, per verificare il rispetto delle normative e per individuare eventuali abusi.
Inoltre, è necessario investire in opere di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Questo significa realizzare interventi di consolidamento dei pendii, di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua, di rinaturalizzazione delle aree degradate e di ripristino della vegetazione.
È necessario promuovere una pianificazione urbanistica attenta e rispettosa dell’ambiente, che tenga conto dei rischi idrogeologici e che limiti il consumo di suolo. È necessario incentivare la riqualificazione degli edifici esistenti, piuttosto che la costruzione di nuovi edifici in aree a rischio.
È necessario promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità, educando i cittadini al rispetto del territorio e informandoli sui rischi a cui sono esposti. È necessario coinvolgere i cittadini e le associazioni ambientaliste nella tutela del territorio, promuovendo la partecipazione attiva e la condivisione delle conoscenze.
Infine, è necessario promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali, limitando la deforestazione, proteggendo le foreste e gestendo il territorio in modo responsabile. È necessario incentivare l’agricoltura di montagna, che contribuisce a mantenere il territorio e a prevenire il dissesto idrogeologico.
Le soluzioni esistono, ma è necessario un impegno concreto da parte di tutti per metterle in pratica. È necessario superare gli interessi particolari e le logiche di corto termine, per mettere al primo posto la sicurezza del territorio e la tutela dell’ambiente. Solo così potremo costruire una montagna più resiliente e sicura, per il bene delle generazioni future.
L’utilizzo di tecnologie avanzate per il monitoraggio del territorio e la previsione dei rischi rappresenta un valido supporto per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Sensori, droni e satelliti possono fornire dati preziosi sullo stato del territorio, permettendo di individuare precocemente i segnali di rischio e di intervenire tempestivamente.
Un appello alla responsabilità e alla cura del territorio
Le valanghe di fango in Valsesia e Mompantero ci hanno ricordato, ancora una volta, quanto sia fragile il nostro territorio e quanto sia urgente intervenire per evitare nuove catastrofi. Non possiamo più permetterci di assistere impotenti al ripetersi di queste tragedie. È il momento di agire, con coraggio e determinazione, per proteggere le nostre montagne e le nostre comunità.
È necessario un cambio di mentalità, un impegno concreto da parte di tutti per una gestione del territorio più responsabile e sostenibile. È necessario superare gli interessi particolari e le logiche di corto termine, per mettere al primo posto la sicurezza del territorio e la tutela dell’ambiente.
Le montagne sono un bene prezioso, un patrimonio da tutelare per il bene delle generazioni future. Non possiamo più permettere che vengano deturpate dalla speculazione edilizia e dall’incuria del territorio. È necessario proteggerle, valorizzarle e gestirle in modo sostenibile, per garantire un futuro sicuro e prospero alle comunità alpine.
L’abusivismo edilizio, i controlli mancati e la gestione irresponsabile del territorio sono ferite che sanguinano nel cuore delle nostre montagne. È necessario curarle, risanarle e prevenire che si ripetano. È necessario unire le forze tra amministrazioni locali, proprietari degli immobili, professionisti del settore, associazioni ambientaliste e cittadini, per costruire una montagna più resiliente e sicura.
Le valanghe di fango ci hanno dimostrato, ancora una volta, quanto sia importante la prevenzione del dissesto idrogeologico. È necessario investire in opere di consolidamento dei pendii, di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua, di rinaturalizzazione delle aree degradate e di ripristino della vegetazione.
È necessario promuovere una pianificazione urbanistica attenta e rispettosa dell’ambiente, che tenga conto dei rischi idrogeologici e che limiti il consumo di suolo. È necessario incentivare la riqualificazione degli edifici esistenti, piuttosto che la costruzione di nuovi edifici in aree a rischio.
È necessario promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità, educando i cittadini al rispetto del territorio e informandoli sui rischi a cui sono esposti. È necessario coinvolgere i cittadini e le associazioni ambientaliste nella tutela del territorio, promuovendo la partecipazione attiva e la condivisione delle conoscenze.
Solo così potremo costruire una montagna più resiliente e sicura, per il bene delle generazioni future. Solo così potremo onorare la bellezza e la forza delle nostre montagne, proteggendole dalla follia umana e dai rischi del futuro.
Montagna Fragile: Oltre la Cronaca, Verso la Consapevolezza
Questi eventi, purtroppo non isolati, ci spingono a una riflessione più profonda. Non si tratta solo di cronaca, di registrare l’ennesima tragedia annunciata, ma di comprendere le cause profonde che la generano. La fragilità della montagna è un tema che riguarda tutti noi, non solo chi la abita. È un tema che interroga il nostro rapporto con la natura, con il territorio, con le risorse.
La montagna è un sistema complesso e delicato, in cui ogni elemento è interconnesso. Alterare questo equilibrio, costruire senza criterio, sfruttare le risorse senza rispetto, significa mettere a rischio la sua stabilità e la nostra sicurezza. È necessario imparare a convivere con la montagna, a rispettarla, a proteggerla.
Amici appassionati di montagna, alpinisti e amanti della natura, di fronte a queste notizie è facile sentirsi impotenti. Ma non dobbiamo cedere allo sconforto. La conoscenza è il primo passo per agire. Approfondire le dinamiche del dissesto idrogeologico, comprendere le cause dell’abusivismo edilizio, informarsi sulle politiche di gestione del territorio, sono azioni concrete che possiamo intraprendere per diventare cittadini più consapevoli e responsabili.
Un concetto base da tenere a mente è che la stabilità di un versante montano dipende da un equilibrio delicato tra la forza di gravità che tende a far franare il terreno e la resistenza offerta dalla roccia, dal suolo e dalla vegetazione. L’intervento umano, con costruzioni, disboscamenti o modifiche dei corsi d’acqua, può alterare questo equilibrio, aumentando il rischio di frane.
Un concetto più avanzato, invece, riguarda la valutazione del rischio idrogeologico, che si basa sull’analisi della pericolosità (la probabilità che si verifichi un evento franoso), dell’esposizione (il valore dei beni e delle persone che potrebbero essere danneggiati) e della vulnerabilità (il grado di danno che un determinato elemento può subire a causa dell’evento). Comprendere questi concetti è fondamentale per valutare criticamente le scelte politiche e le azioni concrete intraprese per la gestione del territorio montano.
Che ne dite, quindi, di trasformare la rabbia e la frustrazione in un impegno attivo per la tutela della montagna? Informiamoci, discutiamone, partecipiamo alle decisioni che riguardano il nostro territorio. Solo così potremo contribuire a costruire un futuro più sicuro e sostenibile per le nostre amate montagne. E magari, la prossima volta che ci troveremo a scalare una vetta, potremo farlo con la consapevolezza di aver fatto la nostra parte per proteggerla.
- ARPA Piemonte fornisce dati e informazioni sullo stato dell'ambiente, incluso rischio idrogeologico.
- Scheda comunale di Mompantero (Città Metropolitana di Torino) con dati sull'assetto idrogeologico.
- Mappa del pericolo attuale di rischio idrogeologico in Piemonte, fonte di ARPA.
- Aggiornamenti sulla visualizzazione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni sul Geoportale.